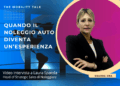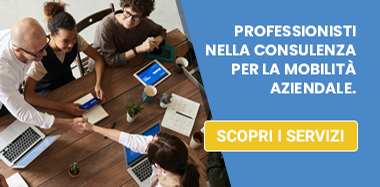Per molto tempo il viaggio aziendale è stato considerato un ingranaggio del sistema produttivo. Una funzione da gestire, una voce di costo da tenere sotto controllo.
Il travel manager era il garante dell’efficienza: tariffe, policy, saving, fornitori.
Un lavoro tecnico, preciso, necessario.
Negli ultimi anni però la scena è cambiata.
Il viaggio non si riduce più a spostamento o logistica, ma entra nella sfera del benessere e della qualità del lavoro.
Chi parte rappresenta l’azienda ma vive anche un’esperienza personale: ritmi, distanze, tempo, equilibrio.
Ogni trasferimento tocca la vita delle persone e incide sul loro modo di lavorare, di relazionarsi, di percepire il proprio valore.
Questo cambiamento modifica anche il ruolo del travel manager.
Da gestore di costi diventa un professionista che progetta esperienze di lavoro.
Il suo compito si allarga: definisce tempi di viaggio sostenibili, promuove scelte coerenti con i valori aziendali, contribuisce al benessere di chi si muove.
Ogni dettaglio – dall’orario di partenza alla durata delle tappe, dalla selezione dei fornitori alla qualità degli spazi – entra a far parte di un sistema che misura non solo l’efficienza, ma anche la cura.
Per questo la collocazione tradizionale nell’area acquisti oggi appare limitante.
Il viaggio d’affari si è spostato sul terreno delle persone, e quel terreno appartiene alle Risorse Umane.
Lì si parla di equilibrio, di sostenibilità, di fiducia.
Lì si costruiscono politiche che tengono conto delle differenze, dei bisogni e delle energie.
In quell’ambiente il travel management trova una dimensione più completa, capace di unire numeri e significato.
La pandemia ha accelerato questa consapevolezza.
Ha mostrato quanto la mobilità influenzi la vita quotidiana e quanto la qualità dei viaggi incida sulla produttività e sulla motivazione.
Molte aziende hanno iniziato a ripensare i propri modelli: meno viaggi superflui, più esperienze mirate, maggiore attenzione alla salute e al tempo.
Da quel momento la trasferta ha smesso di essere solo un costo e ha cominciato a rappresentare un investimento relazionale.
L’integrazione tra Procurement e HR diventa quindi la chiave per interpretare il presente.
Gli acquisti garantiscono metodo e sostenibilità economica, le HR portano visione e attenzione alle persone.
Il dialogo tra queste due funzioni permette di costruire un modello equilibrato, dove efficienza e benessere non si escludono ma si sostengono a vicenda.
Il viaggio diventa così uno spazio di relazione che restituisce valore all’impresa e a chi la rappresenta.
Il travel manager del futuro vive in questo equilibrio.
Conosce i processi ma osserva le persone, gestisce i dati ma ascolta le storie, traduce la strategia aziendale in esperienze concrete.
La sua competenza attraversa funzioni e linguaggi, unisce logica e sensibilità, misura risultati che si riflettono sul clima interno e sulla reputazione dell’azienda.
Il viaggio d’affari racconta come un’organizzazione interpreta la propria cultura.
Chi lo gestisce con attenzione costruisce fiducia, appartenenza, coerenza.
Collocare il travel manager accanto alle Risorse Umane significa riconoscere che la mobilità è parte della vita lavorativa, non un servizio esterno.
Significa investire su un modo di muoversi più consapevole, più equilibrato, più vicino alle persone.
In questa prospettiva, il business travel diventa un laboratorio di cultura aziendale.
Ogni partenza esprime una scelta, ogni ritorno restituisce un segno.
Dentro questo movimento il travel manager trova la sua nuova posizione: un punto di incontro tra efficienza e umanità, tra metodo e attenzione, tra organizzazione e cura.