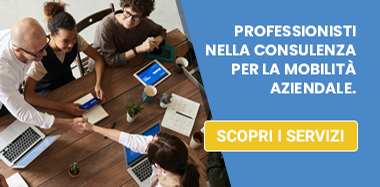La mia riflessione di oggi nasce da un episodio che, pur essendo rimasto confinato all’interno dell’azienda coinvolta e di cui sono venuta a conoscenza quasi per caso, ha avuto un impatto profondo sui colleghi e sui vertici: un professionista ha perso la vita durante il tragitto casa–lavoro, mentre si spostava con un mezzo a due ruote. Non si tratta di un caso isolato né di un fatto da esporre pubblicamente, ma di una di quelle circostanze che costringono le imprese a interrogarsi con realismo su come vengono concepite le politiche di mobilità aziendale. Episodi come questo – purtroppo non rari nel Paese – rendono evidente che gli spostamenti quotidiani non sono mai “neutri”, e che la mobilità non può essere affrontata solo come un tema di sostenibilità o di compliance normativa.
L’incidente è diventato il punto di avvio di una riflessione più ampia, che riguarda tutte le organizzazioni: quanto conosciamo davvero i rischi legati agli spostamenti dei nostri dipendenti? E quanto le nostre strategie – spesso orientate alla riduzione delle emissioni o alla risposta formale alle richieste dei Comuni – riescono a tenere conto dell’effettiva sicurezza delle persone?
Il contesto nazionale aiuta a comprendere la portata del problema. Nel 2024, secondo i dati ISTAT, in Italia si sono registrati oltre 173 mila incidenti con lesioni a persone, più di tremila vittime e quasi 234 mila feriti. Gli utenti vulnerabili – motociclisti, ciclisti, pedoni – continuano a rappresentare una quota rilevante della mortalità. In parallelo, il costo sociale degli incidenti ha superato i 18 miliardi di euro. Sono dati che, collegati a episodi aziendali concreti come quello citato, indicano con chiarezza che il rischio connesso agli spostamenti ordinari non può essere sottovalutato.
Ed è proprio qui che emerge una criticità diffusa: molte imprese affrontano il Piano Spostamenti Casa–Lavoro (PSCL) come un passaggio amministrativo, limitandosi a raccogliere i dati sul modo in cui i dipendenti si spostano per poi trasmetterli al Comune e ai mobility manager di aerea. Percentuali, tabelle, distribuzioni modali: numeri utili, ma insufficienti. Una fotografia, non una strategia. In questo schema semplificato – radicato e assai, purtroppo, diffuso – manca ciò che dovrebbe costituire il cuore della pianificazione: l’analisi qualitativa dei percorsi, dei rischi effettivi, delle infrastrutture disponibili, delle condizioni dei tragitti e della loro compatibilità con gli obiettivi di sostenibilità.
Il risultato è un cortocircuito concettuale: si promuove la mobilità sostenibile, spesso stimolando l’uso di mezzi green o leggeri, senza valutare se i tragitti reali siano adatti e sicuri per quei mezzi; al tempo stesso, si assume che la sicurezza imponga necessariamente modelli più tradizionali, che però non rispondono alle esigenze ambientali e di efficienza imposte dal contesto attuale. L’equilibrio tra sostenibilità e sicurezza diventa così una questione di progettazione e non di preferenze ideologiche?
La mobilità casa–lavoro è un fenomeno collettivo con implicazioni economiche, sociali e umane. Riguarda le imprese, i lavoratori, le istituzioni, ma anche il sistema Paese nel suo complesso. Le scelte su come ci muoviamo non sono mai neutre: generano effetti, costi, benefici e rischi che devono essere compresi e gestiti. Il punto non è individuare una soluzione unica, né decretare la superiorità di una modalità rispetto a un’altra. Il punto è costruire piani che tengano insieme le due forze che plasmano la mobilità contemporanea: sostenibilità e sicurezza. Perché solo quando entrambe vengono considerate in modo integrato si può definire una mobilità davvero responsabile, capace di proteggere le persone senza rinunciare agli obiettivi climatici e strategici del futuro.
Per questo incidenti come quello da cui nasce questa riflessione devono essere letti come un segnale, non come un’anomalia. Mostrano che la mobilità casa–lavoro non è un tema marginale delle politiche aziendali, ma un ambito in cui scelte superficiali o documenti compilati per obbligo possono avere conseguenze molto concrete. Ecco perché un PSCL credibile richiede un salto di qualità: non un elenco di dati, ma una progettazione integrata che incroci sostenibilità, sicurezza e contesto territoriale.
In questo processo la consulenza specializzata ha un ruolo determinante: figure esperte – come quelle di Travel for business – sono in grado di trasformare un obbligo normativo in uno strumento di governo aziendale, capace di coniugare obiettivi ESG, efficienza organizzativa e tutela delle persone. Solo così un PSCL può aspirare non a essere un esercizio formale, ma un vero strumento di responsabilità sociale e di protezione del capitale umano.
Ripartire da un singolo incidente per rivedere l’intero modello di mobilità può sembrare una reazione forte. In realtà, è esattamente ciò che distingue un adempimento da una politica responsabile.
.
Foto di Filmy Kashif: https://www.pexels.com/it-it/foto/34941220/