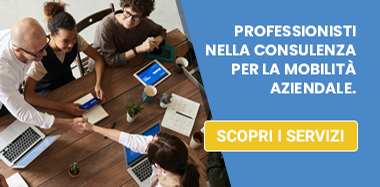Il lavoro da remoto continua a ridisegnare geografie, abitudini e perfino modelli economici. In Italia, secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2024 si contano oltre 3,5 milioni di lavoratori da remoto, un incremento del 17% rispetto al 2022. È una crescita che non riguarda solo le grandi città: sempre più professionisti scelgono di spostarsi in località minori, in cerca di qualità della vita, natura e connessioni più umane.
Parallelamente, si consolida il fenomeno della workation, la combinazione di vacanza e lavoro. Il 32% dei viaggiatori italiani l’ha già sperimentata, mentre il 41% dei lavoratori da remoto ha trascorso almeno parte dell’anno in una località turistica (fonte: EY Future Travel Behaviours 2025). Un’evoluzione che mette in discussione i modelli tradizionali di turismo, spingendo verso forme di ospitalità più diffuse e flessibili.
Eppure, il potenziale resta in gran parte inespresso. Oggi il 75% dei visitatori si concentra su appena il 4% del territorio nazionale (TEHA Group). Le aree interne e rurali, pur offrendo spazi, identità e silenzio, restano spesso escluse dai grandi flussi.
Sommario
ToggleAree interne e innovazione: un binomio possibile
Negli ultimi anni, diversi progetti di ricerca hanno provato a indagare come il lavoro a distanza possa intrecciarsi con la rigenerazione dei territori. Tra questi, DESK(T), iniziativa sviluppata nell’ambito del Partenariato Esteso MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, coordinato dal Politecnico di Milano, ha esplorato il rapporto tra design, tecnologia e nuovi stili di vita rurali.
Il progetto, realizzato con il contributo di università e imprese, si è concentrato su un aspetto concreto: come migliorare la qualità dell’esperienza lavorativa in contesti non urbani, e in che modo questo possa favorire economie locali legate all’ospitalità sostenibile. Tra gli esiti, la progettazione di una scrivania multifunzionale e a basso impatto ambientale, pensata come elemento di arredo per spazi di lavoro temporanei in strutture ricettive rurali.
Si tratta di un esperimento di integrazione tra ricerca applicata e sviluppo territoriale. Un esempio di come la questione del lavoro agile possa essere affrontata non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche attraverso la progettazione dello spazio e del rapporto con i luoghi.
Nuove economie della lentezza
La ricerca legata a DESK(T) ha evidenziato come l’introduzione di postazioni di lavoro “smart” in agriturismi, B&B e borghi diffusi possa contribuire alla destagionalizzazione del turismo, favorendo permanenze più lunghe e un diverso equilibrio tra vita professionale e tempo libero. Una dinamica che, se consolidata, potrebbe generare nuove microeconomie locali, legate non solo all’accoglienza ma anche ai servizi, all’artigianato e alla manutenzione del paesaggio.
Non è un caso isolato. Dalla Toscana all’Abruzzo, si moltiplicano le iniziative che provano a intercettare i lavoratori in mobilità: spazi di co-living rurale, coworking diffusi, borghi digitali. Tuttavia, restano sfide aperte — dalla qualità delle connessioni internet alla scarsità di infrastrutture e servizi — che rendono il fenomeno ancora frammentato.
Come sottolinea Nicolas Verderosa, tra i promotori del progetto e fondatore della startup Ruralis, “le aree interne possono diventare luoghi di sperimentazione per nuovi equilibri tra sostenibilità, lavoro e comunità locale”. Ma, aggiungono gli osservatori del settore, ciò richiede visione politica e continuità di investimenti.
Oltre il lavoro agile
Il lavoro a distanza, dopo la spinta pandemica, entra ora in una fase di maturità. Non è più solo una questione di efficienza aziendale, ma di modelli di vita e riorganizzazione territoriale. Le aree rurali italiane, spesso percepite come periferiche, potrebbero trasformarsi in laboratori del futuro: non per rincorrere le città, ma per offrire un’alternativa credibile e sostenibile. Un futuro ancora in costruzione. Ma che, in molti casi, comincia già da una scrivania affacciata sui campi.