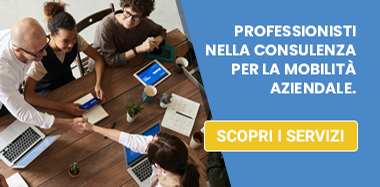Sommario
ToggleStretta sui controlli sui socia per l’ingresso USA. Le novità sollevano dubbi su privacy, tempi e libertà digitale di studenti e professionisti
L’ESTA non basta più. Gli Stati Uniti hanno progressivamente ampliato i criteri di controllo per chi desidera entrare nel Paese. Ma con la presidenza Trump, la stretta sui visti F, M e J è di fronte ad un ulteriore cambio di paradigma. Dal 30 giugno 2025, chi fa domanda per uno di questi visti per gli Stati Uniti dovrà non solo dichiarare l’elenco dei propri profili social utilizzati negli ultimi cinque anni, ma anche assicurarsi che siano pubblicamente accessibili. Non è più sufficiente comunicare un nome utente: ora le autorità vogliono vedere con i propri occhi cosa viene pubblicato, commentato, condiviso, con chi si interagisce e in che modo.
L’intento dichiarato è quello di rafforzare la sicurezza nazionale, prevenendo l’ingresso nel Paese di individui ritenuti potenzialmente pericolosi o ambigui. Ma il fatto che questi controlli si estendano a contenuti personali pubblicati spesso per svago o per socialità solleva questioni importanti: dove finisce la sicurezza e dove inizia la sorveglianza?E, soprattutto, fino a che punto un post pubblicato cinque anni prima può pesare su un progetto di studio o carriera?
Ingresso Stati Uniti: la novità
La nuova normativa riguarda in primis studenti internazionali, partecipanti a scambi culturali, ricercatori e tirocinanti. Tuttavia, il suo impatto si estende ben oltre il mondo accademico. In molte situazioni aziendali, infatti, professionisti e manager sono coinvolti in percorsi di formazione temporanea, internship, programmi di ricerca e scambi sponsorizzati da imprese multinazionali. È il caso, ad esempio, di figure junior inserite in progetti transnazionali o di lavoratori distaccati presso sedi americane per brevi periodi.
Chi viaggia per motivi professionali e ricade in una delle categorie F, M o J deve sottostare alle stesse regole.Questo significa che anche le imprese italiane e internazionali che inviano personale negli USA dovranno rivedere procedure e protocolli interni. La formazione in materia di compliance digitale, le linee guida per la gestione dei profili social e l’allineamento con le policy HR diventano strumenti essenziali per evitare blocchi o ritardi nelle missioni all’estero.
Come funzionano i controlli per entrare negli USA
Il processo di analisi delle identità digitali non è più lasciato alla discrezione di pochi funzionari. È diventato parte integrante delle pratiche consolari. Quando si compila il modulo DS-160 (per i visti F e M) o si riceve il modulo I-20 (dalle università o enti sponsor), è ora obbligatorio fornire tutti i nomi utente dei social media utilizzati negli ultimi cinque anni. Le piattaforme interessate sono molteplici: Facebook, Instagram, TikTok, X (ex Twitter), LinkedIn, ma anche social meno comuni, a seconda del Paese di origine del richiedente.
Il controllo non si limita a verificare l’autenticità dell’account: viene esaminato l’intero comportamento digitale pubblico, dalle foto pubblicate ai commenti lasciati su contenuti altrui, dalle interazioni con pagine tematiche alla partecipazione a gruppi. La finalità è individuare elementi che possano far emergere simpatie per ideologie estremiste, affiliazioni politiche radicali, dichiarazioni fuorvianti o incompatibili con il profilo dichiarato nella richiesta di visto. In caso di discrepanze – ad esempio tra il tipo di percorso accademico dichiarato e quanto appare sul profilo LinkedIn – o di contenuti considerati problematici, il consolato può sospendere la domanda in attesa di approfondimenti o convocare il richiedente per un’intervista supplementare.
Conseguenze degli ingressi in USA
Le nuove procedure hanno già sollevato un acceso dibattito. Uno dei primi effetti concreti riguarda l’aumento dei tempi di attesa: se il personale consolare deve analizzare centinaia di post, foto e commenti per ciascun richiedente, le tempistiche di risposta si allungano inevitabilmente. Per chi ha scadenze accademiche o lavorative ravvicinate, questo può rappresentare un ostacolo significativo.
Ma il punto più delicato resta quello legato alla tutela della privacy. Secondo associazioni per i diritti civili come l’ACLU, questi controlli si avvicinano pericolosamente alla sorveglianza di massa, alimentando la possibilità di giudizi arbitrari e discriminatori. È vero che negli Stati Uniti il DHS già da anni ha facoltà di inserire nei fascicoli d’immigrazione dati social, pseudonimi e cronologie. Tuttavia, ciò che oggi cambia è la sistematicità del controllo e l’obbligo esplicito di rendere visibile ciò che, in teoria, ogni utente dovrebbe poter scegliere se condividere o meno.
Andare in America è più difficile
I riflessi di questa politica si fanno sentire in modo tangibile. Per i singoli individui, la richiesta di visto non è più una semplice procedura burocratica: diventa un atto di esposizione della propria identità digitale. Molti richiedenti si trovano costretti a cancellare contenuti, modificare le impostazioni dei profili o persino aprire account alternativi da presentare al consolato. Questo genera ansia e incertezza, soprattutto tra i più giovani, che vedono nella loro presenza online uno spazio privato, ironico, creativo, spesso scollegato da finalità lavorative o accademiche.
Per le aziende, la questione è ancora più complessa. Chi si occupa di mobility management, HR o formazione deve oggi garantire che i dipendenti selezionati per viaggi negli USA siano informati sui nuovi requisiti e preparati a gestire la propria identità digitale in modo coerente. In un contesto sempre più interconnesso, anche un like fuori posto può diventare un problema per l’intera organizzazione. A livello macro, inoltre, le università americane temono che la nuova stretta scoraggi gli studenti internazionali: nel solo anno 2023-2024, l’apporto economico degli studenti stranieri ha superato i 43 miliardi di dollari. Un crollo delle iscrizioni avrebbe conseguenze economiche dirette su centri di ricerca, campus e intere comunità locali.
Cosa serve per entrare negli Stati Uniti
La nuova realtà richiede un approccio strutturato. Chiunque intenda presentare domanda per un visto statunitense deve effettuare una revisione approfondita della propria presenza digitale, con attenzione non solo ai contenuti pubblicati, ma anche alle informazioni biografiche, alle date, alle affiliazioni, alle dichiarazioni implicite. Tutto deve essere coerente con quanto dichiarato nei moduli ufficiali.
Un consiglio pratico è quello di fare un controllo incrociato tra il proprio curriculum, i dati riportati sul DS-160 e quanto risulta su piattaforme professionali come LinkedIn. In alcuni casi, può essere utile viaggiare con dispositivi mobili ridotti, minimizzando l’esposizione. Le aziende, a loro volta, dovrebbero predisporre piccoli audit interni, checklist, e momenti formativi per i dipendenti, in modo da evitare errori grossolani e gestire in anticipo eventuali criticità. Rimanere aggiornati tramite fonti ufficiali – come travel.state.gov, i portali delle ambasciate e il Federal Register – è oggi una condizione imprescindibile per chi lavora nel settore viaggi o formazione.
Non solo USA
L’approccio statunitense non è isolato. Altri Paesi come Canada, Regno Unito e Australia stanno sperimentando forme di controllo simili, anche se spesso meno invasive. Tuttavia, gli Stati Uniti si pongono oggi come punto di riferimento – o di rottura – in questa nuova forma di controllo digitale. La tendenza globale sembra chiara: la sicurezza si costruisce anche (o soprattutto) attraverso l’analisi dei comportamenti online.
Non è ancora chiaro se un eventuale cambio di amministrazione americana potrebbe invertire la rotta o attenuare queste misure. Ma per il momento, lo scenario più realistico è quello di un consolidamento delle procedure, con l’estensione dei controlli anche ad altre categorie di visto e, forse, ad altri settori. Il rischio è che, nel prossimo futuro, la reputazione digitale diventi una condizione implicita per viaggiare, al pari del passaporto o dell’assicurazione sanitaria.
Photo credit: Following NYC